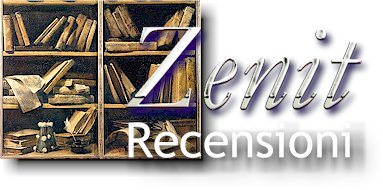|
Un politologo e un
avvocato quale competenza hanno per parlare di massoneria? Parecchia se l’avvocato è
un uomo di cultura, testimone di molti degli avvenimenti narrati e se il politologo,
dall’esterno, disegna una mappa critica degli avvenimenti in cui la massoneria è
stata coinvolta a torto o a ragione.
Diciamo subito che i capitoli più interessanti tra quelli firmati da Massimo della Campa
sono a nostro avviso quelli che attraversano gli anni dalla gran maestranza Gamberini alla
gran maestranza Gaito. Non siamo in presenza di un testo di storia. Queste pagine vanno
lette come una testimonianza, come una fonte: in altre parole ci troviamo di fronte ad un
diario, a delle memorie quale che sia il titolo del libro.
Tralascio i capitoli iniziali che sarebbe stato forse più opportuno non scrivere proprio.
Ci troviamo infatti in presenza di un ennesimo centone di inesattezze riprese da testi a
loro volta poco affidabili: notizie di seconda o terza mano mai verificate sui documenti.
Su due punti non posso però tacere: come si fa a parlare di massoneria deviata per tutta
la storia dell’istituzione fino al riconoscimento inglese del 1972? Non è un
po’ esagerato e forse antistorico?
Lo spirito critico fa difetto ai massoni e soltanto la ricerca scientifica può spiegare
il senso di un impegno sociale vasto e significativo che rende comprensibili le
motivazioni di chi entrava in massoneria in età liberale mentre si fa più fatica a
trovare risposte alla domanda su che cosa cercano e/o trovano oggi i fratelli
nell’appartenenza a questa istituzione. Non a caso tra quelli «che ci credono»
serpeggia una grande inquietudine.
La seconda questione è invece legata alla nascita a Roma nel marzo del 1877 della loggia Propaganda
massonica voluta dal Gran Maestro Giuseppe Mazzoni che ne era anche il Venerabile. Fu
creata per permettere ai fratelli con incarichi di lavoro a Roma, ma la residenza lontano,
di poter essere massoni attivi. Chiunque abbia studiato gli elenchi della matricola
generale del Goi si è reso conto che non si trattava di una loggia segreta. I nominativi
dei fratelli iniziati in questa loggia sono infatti mischiati a quelli di tutti gli altri.
La particolarità era data dal fatto che le iniziazioni venivano fatte durante lo
svolgimento delle Giunte e che vi entravano solo personaggi di spicco.
Ben diverso è l’interesse che meritano invece le pagine che trattano la storia del
Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani nel secondo dopoguerra: dalla politica
filoamericana di Publio Cortini alla lunga marcia di avvicinamento agli inglesi operata da
Giordano Gamberini. Molte pagine sono dedicate a raccontare le vicende di Palazzo
Giustiniani e a spiegare il lungo travaglio della P2; l’adozione in Italia del rito
di York e le complesse vicende che hanno visto il Goi ora attaccato dagli americani ora
dagli inglesi. Le grandi maestranze di Salvini, Battelli, Corona, Di Bernardo, Gaito sono
raccontate da un coprotagonista!
E’ invece l’avvocato che racconta le incredibili vicende legate alla lunga ed
inconsistente inchiesta del giudice Cordova. Colpisce il fatto che dopo aver condannato
con la testa tutta la massoneria italiana che ha preceduto la gran maestranza di
Gamberini, della Campa si lasci andare a un elogio di quella stessa massoneria, nel
momento stesso in cui Gamberini decise di recidere i legami col passato.
Scrive infatti della Campa: «Voltate quindi le spalle al vecchio continente....Gamberini
impresse ai suoi atti un’impronta sempre più filo inglese. L’orientamento dei
fratelli del Grande Oriente, rafforzatosi nel tempo, era ancora ben chiaro ed
individuabile. Forte sentimento patriottico; intransigente laicismo; sensibile attenzione
per i più deboli; difesa della libertà e dei diritti umani; stimolo verso, e confronto
con, quella che si è poi chiamata la società civile; innegabile senso dello Stato... Le
condizioni socio-ambientali erano nel frattempo mutate profondamente; ma
l’allontanamento dall’antico tradizionale spirito libero-muratorio italiano fu
accompagnato dall’allentamento dei freni. Il livello morale si abbassò...»
Dunque anche della Campa concorda sul fatto che l’abbandono delle radici storiche che
avevano alimentato l’appartenenza alla comunione non ha giovato al Goi!
Completamente diversa la seconda parte, quella firmata da Giorgio Galli, che ripercorre la
storia dell’Italia del secondo dopoguerra alla luce della «trama massonica»
cercando di chiarire al lettore se e quale ruolo essa abbia svolto nelle vicende più
oscure: da Gladio a De Lorenzo, dal golpe Borghese a Gelli, a Moro.
La sua conclusione è che l’obbedienza di Palazzo Giustiniani «non ha avuto un ruolo
né di promotrice, né di protagonista nelle iniziative e nei progetti eversivi, pur se
singoli massoni, anche autorevoli, vi hanno preso parte...La stessa documentazione conduce
ad analoga conclusione per quanto riguarda la obbedienza di piazza del Gesù».
Condivido anche le considerazioni che seguono e sulle quali i fratelli dovrebbero operare
una seria riflessione: «Escluso il ruolo di promotrice e/o protagonista, la massoneria
storica di Palazzo Giustiniani, della quale particolarmente qui si tratta, e il suo
vertice, hanno una responsabilità di gestione politica, lunga decenni, responsabilità
sotto un duplice profilo: in primo luogo hanno accettato di far apparire
l’istituzione come un soggetto comprimario sulla scena politica; e, in secondo luogo,
non hanno voluto o saputo fare chiarezza, con una franca assunzione di responsabilità,
per quella scelta [Galli la chiama millantato credito] quando la scelta stessa ha
dato luogo a interpretazioni che hanno dato all’istituzione l’immagine di cui
fatica tuttora a liberarsi, sino alla presunzione di una sistematica attitudine
all’illegalità e addirittura a rapporti con il crimine organizzato».
Parole chiarissime che spiegano perché dagli anni Settanta l’interpretazione che
lega mafia-massoneria-Cia-servizi segreti deviati sia diventata un assioma scontato. Di
chi la colpa? Secondo Giorgio Galli la colpa non è della gente, ma proprio del
comportamento dei vertici di Palazzo Giustiniani.
Ma gli anni settanta non sono anche quelli della grande svolta del Goi,
dell’abbandono della tradizione latina a favore di quella anglosassone? Non sarebbe
opportuno che i fratelli italiani si interrogassero seriamente sulla loro storia?
Perché non aprire un dibattito su Zenit
per sentire cosa ne pensano i fratelli sui cambiamenti avvenuti dagli anni ’70 agli
anni ’90 e sulla realtà odierna del GOI?
Anna Maria Isastia |